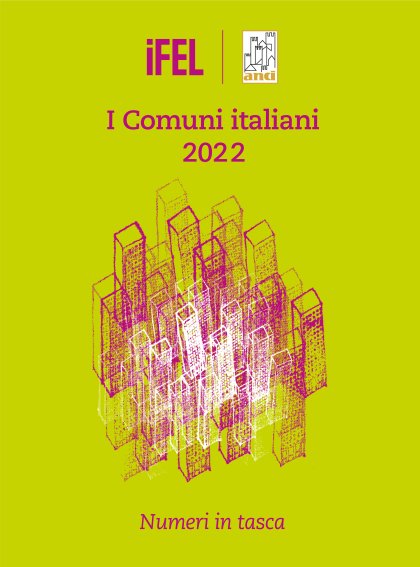Mariangela Parenti
L’obiettivo è quello di fornire un agile strumento di lavoro a quanti - politici, amministratori, studiosi dei fenomeni territoriali - si interrogano sui caratteri ed i cambiamenti in atto nel mondo eterogeneo dei comuni. Un mondo in continua evoluzione che rappresenta saldamente l’elemento unificatore in cui gli italiani si trovano, il luogo dove vivono la propria quotidianità, l’istituzione più vicina alla quale si rivolgono per avere una risposta ai bisogni, alle difficoltà, alla voglia di partecipazione.
Si informa che è stato diffuso un avviso pubblico per la costitizione di n.1 long list per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di attività formative e i supporto nell'ambito della linea di intervento: "Supporto ai processi comununali di investimento" di cui all'art. 57 comma 2-novies del D.L. 124/2019 e relativa Convenzione.
Il testo dell'Avviso e i relativi allegati sono accessibili nel portale Trasparenza della Fondazione IFEL al seguente link.
Torna l’appuntamento annuale con l’Assemblea dell’ANCI, che quest’anno sarà ospitata dal 22 al 24 novembre a Bergamo. Un’edizione che punta, come dichiara lo slogan scelto, “La voce del Paese – La parola alle nostre comunità”, a mettere al centro della tre giorni i territori, i loro bisogni e le risposte che i Comuni, per la loro parte, sono chiamati a risolvere. Un lavoro quotidiano che ha bisogno della cooperazione di tutti i livelli di governo. PNRR, infrastrutture, innovazione, ambiente e sostenibilità, clima, transizione digitale, sono i capitoli che affronteranno i primi cittadini nei numerosi panel che compongono i lavori dell’Assemblea, che saranno aperti, come avviene ormai da diversi anni, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
“L’Assemblea dell’ANCI rappresenta, quest’anno ancor più del passato - spiega il Direttore IFEL Pierciro Galeone - un’opportunità per dare voce ai territori, e a chi è chiamato a rappresentarli, in un momento storico tutt’altro che facile in cui anche i Comuni subiscono le conseguenze di uno scenario internazionale molto critico che proietta ombre minacciose sul nostro futuro e ci impone sfide economiche, sociali ed energetiche”. La Fondazione partecipa all’Assemblea con l’intervento del Presidente Canelli che, il giorno 24 novembre, illustrerà uno degli otto obiettivi che ANCI proporrà al governo per guardare al futuro a partire dai territori. Inoltre, offre ai partecipanti due importanti eventi a latere, momenti di riflessione e approfondimento sul PNRR e sullo stato attuale della finanza locale. "Il tema del supporto ai Comuni è la nostra missione e in questo momento siamo particolarmente impegnati sulla realizzazione degli investimenti. Si rafforzano, inoltre, i servizi formativi della Scuola IFEL - conclude il Direttore - data l’importanza di sostenere e accompagnare la gestione economico finanziaria in vista della transizione digitale ed energetica nella pubblica amministrazione comunale".
I lavori dell’Assemblea sono trasmessi anche in diretta streaming così come gli eventi a latere di IFEL. E' possibile seguire gli incontri IFEL, oltre che in presenza, anche in streaming sul canale youtube della Fondazione.
EVENTI A LATERE
Come usare il Portale di servizi Easy - IFEL | Gli investimenti dei Comuni fra attuazione PNRR e nuova programmazione 2021-2027
24/11/2022 - Ore 10.00 - 11.30
Sala Serio
Nel corso dell’evento verranno illustrate le attività di supporto che IFEL, nell’ambito di una Convenzione con MEF-MINT, garantisce ai Comuni italiani sui temi del ciclo degli investimenti (aggiuntivi) co-finanziati dalle politiche europee (PNRR- Fondi SIE) e da fondi nazionali e regionali. In particolare, saranno approfonditi gli interventi realizzati con la Piattaforma EASY-INVESTIMENTI.
PROGRAMMA
DIRETTA STREAMING
I Comuni al centro delle riforme. La sfida del PNRR - V Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni
24/11/2022 - Ore 11:30 - 13:00
Sala Serio
Il Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni italiani, giunto alla V edizione, si pone l’obiettivo di fare il punto circa lo stato dei principali processi di trasformazione del sistema locale in un contesto caratterizzato da nuove emergenze proprio quando la crisi pandemica sembrava ormai alle spalle. Il Rapporto ha ampliato nel tempo il proprio campo di osservazione alle riforme necessarie al ripristino di una ordinaria gestione e al pieno ed efficace esercizio delle funzioni.
PROGRAMMA
DIRETTA STREAMING
Presso lo stand IFEL, infine, sarà possibile consultare in anteprima le nuove pubblicazioni e materiali informativi che saranno successivamente disponibili anche sul sito della Fondazione:
- Guida alla predisposizione del PEF secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA (di prossima pubblicazione)
- Personale comunale e formazione: competenze e scenari- Terza edizione 2022
- I Comuni italiani 2022 - Numeri in tasca
- La dimensione territoriale nelle Politiche di Coesione - Stato di attuazione e ruolo dei Comuni nella programmazione 2014-2020 e 2021-2027. Dodicesima edizione-2022
- Piattaforma EASY: servizi di supporto agli investimenti
- EASY |Approfondimenti tecnici. Supporto all’applicazione del principio di non arrecare danno significativo DNSH
- Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei Comuni - Programma di interventi pluriennale 2021-2023
Scoprili in anteprima in questo video:
Lunedì 14 novembre 2022 ripartono i webinar formativi previsti dal Piano nazionale di formazione per l’aggiornamento professionale dei RUP - annualità 2022-2023 - nell’ambito della PNRR ACADEMY, realizzata dalla Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims)- Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere e ITACA, IFEL e SNA, in collaborazione con la rete nazionale degli Osservatori regionali, Anac e Consip.
Per consultare il programma formativo completo del Piano nazionale clicca qui.
I webinar
I webinar, previsti dalla Unit 1 (Formazione di base) - Linea 2, sono finalizzati all’aggiornamento tecnico operativo dei RUP e del personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. La Unit 1 si articola in 4 Moduli, ciascuno dei quali prevede 3 webinar, propedeutici tra loro, della durata di 2 ore ciascuno. Al termine di ciascun Modulo è previsto un test di valutazione (domande a risposta multipla), al superamento del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Questi i 4 moduli in programma:
MODULO 1 «Dalla programmazione alla progettazione»: Programma e calendario - ISCRIVITI
MODULO 2 «Dalla gara all’aggiudicazione» (in fase di programmazione)
MODULO 3 «Dalla stipula del contratto alla sua conclusione» (in fase di programmazione)
MODULO 4 «Concessioni e partenariato pubblico privato» (in fase di programmazione)
I webinar saranno registrati e consultabili on line sulla piattaforma nazionale. Al termine di ciascun Modulo formativo, coloro che avranno seguito almeno il 70% delle ore formative potranno sostenere il test di valutazione.
Chi può partecipare
A ciascun webinar potranno partecipare fino ad un massimo di 1.000 discenti appartenenti all’ambito regionale cui l’edizione è rivolta. In caso di overbooking, sarà disponibile entro le 24 ore dalla conclusione dell’evento online, la registrazione del webinar che sarà consultabile direttamente in piattaforma e consentirà a tutti gli utenti di poter ottenere l’attestato di partecipazione.
Informazioni utili
Tutte le attività formative saranno erogate, gratuitamente, nell’ambito della Piattaforma Nazionale di Formazione per il Responsabile Unico del Procedimento.
Per iscriversi ai webinar, accedere alla piattaforma. L’iscrizione consentirà di partecipare all'incontro utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma, pertanto non sarà necessario iscriversi a ogni singolo webinar. I link per accedere alla diretta saranno disponibili 15 minuti prima dell’inizio di ogni evento.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo: .
Si terrà l’11 novembre, presso l'Urban Center di Rovereto, l’evento di presentazione del volume L'altra faccia della Luna - Comuni ai margini tra quotidianità e futuro, promosso da IFEL ed edito da Rubbettino.
Il volume, articolato in quattro parti e costruito grazie al contributo di 28 autori, è un racconto a più voci sull’universo di migliaia di Comuni ai margini, fragili e interni che fanno del Paese la ricchezza del nostro territorio ma che, sempre più spesso, devono affrontare una serie di problemi impegnativi e complessi, a partire dal grave indice di spopolamento che Gian Carlo Blangiardo, Presidente ISTAT, nel suo contributo, chiama inverno demografico.
A raccontare la dimensione territoriale della marginalità e a illustrare i focus specifici che compongono il volume, dai servizi di cittadinanza, alla scuola, passando per la medicina di prossimità e la mobilità sostenibile solo per citarne alcuni, vi saranno, oltre ai referenti istituzionali locali, anche i curatori del volume: Francesco Monaco e Walter Tortorella di IFEL.L’appuntamento è per le ore 18.00, presso il piano terra dell’Urban Center di Rovereto. L’evento è aperto a tutti gli interessati fino ad esaurimento posti. E’ possibile iscriversi qui o scrivendo a: .