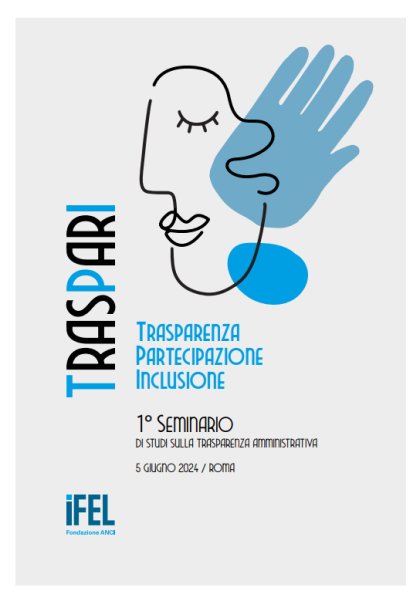Mariangela Parenti
Il sindaco di Novara, delegato alla Finanza locale e Presidente IFEL intervenendo davanti alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, chiede certezze e garanzie sul finanziamento delle funzioni fondamentali e dei servizi che dobbiamo erogare.
“Le ipotesi di fiscalizzazione dei trasferimenti statali alle Regioni che fin qui abbiamo sentito, ovvero di sostituire i trasferimenti dello Stato alle Regioni con compartecipazioni regionali a tributi erariali senza vincolo di destinazione, coinvolgono funzioni fondamentali dei Comuni per la metà dei circa dei 10 mld. di fondi individuati. Un importo molto rilevante che attualmente finanzia in modo diretto - anche con l'intervento di una programmazione regionale - spese comunali in materie decisive come scuola, servizi sociali e trasporto pubblico locale. Per questo chiediamo un approfondimento tecnico e politico che permetta di salvaguardare le prerogative, anche costituzionali, di tutti gli enti territoriali e assicuri l'integrale copertura delle funzioni fondamentali dei Comuni". Lo ha sottolineato Alessandro Canelli, Sindaco di Novara, delegato alla Finanza locale e Presidente IFEL intervenendo davanti alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.
Canelli ha ribadito che i Comuni “non sono affatto contrari all’attuazione del federalismo fiscale del quale vorremmo essere maggiormente protagonisti come comparto. La nostra preoccupazione è che gli enti locali siano tutelati sulla copertura finanziaria delle funzioni legate alla lotta alla povertà e all’integrazione sociale, su cui quali noi facciamo affidamento essendo le amministrazioni in prima linea nell’erogazione di questi servizi ai cittadini”.
Il delegato ANCI si è poi soffermato sul meccanismo di perequazione attuato in questi anni per colmare il divario tra le risorse donate dai Comuni con più capacità fiscali verso quelli con meno capacità fiscale. “Grazie ai 560 milioni riassegnati ai Comuni, dopo essere stati tolti con il dl 66 del 2014, siamo riusciti a fare in modo che gli enti che conferivano risorse al fondo di solidarietà comunale per i Comuni con minore capacità fiscale, così come prevedeva il target perequativo, mantenessero il proprio livello di entrata”. Il nostro comparto è riuscito “a mantenere questa dinamica in un contesto finanziario estremamente difficile specie sulla parte corrente dei bilanci comunali”, ha aggiunto.
Per questo il delegato ANCI ha salutato con favore la novità introdotta dall’ultima legge di bilancio che “per la prima volta ha riconosciuto che ci fosse l'opportunità da parte del Mef e quindi del governo di finanziare almeno in parte la perequazione con risorse statali”. Per l’Anci è importante che “venga riconosciuto il principio costituzionale che anche lo Stato deve compartecipare a processo perequativo. Lo farà – ha argomentato - con 56 milioni di euro di perequazione verticale che andranno a crescere fino al 2030 per raggiungere la cifra di 310 milioni di euro, consentendo di compartecipare al 50% al progressivo processo di aumento del target perequativo”.
Infine, sull’attuazione della delega fiscale Canelli ha espresso l’auspicio che sia un'occasione per avvicinare l'assetto finanziario dei Comuni al quadro delineato della Costituzione. “Come comparto dei Comuni abbiamo bisogno di maggiore manovrabilità e elasticità delle entrate, come peraltro indicato dalla stessa legge delega, ma è chiaro che i Comuni intendono fare la loro parte sul tema della riscossione, che va migliorata”, ha evidenziato. La delega è una grande occasione per rivedere l'assetto complessivo della finanza pubblica locale nel nostro Paese", ha concluso Canelli.
Il programma completo è disponibile qui.
Come partecipare
Per partecipare è necessario iscriversi qui. Per permettere a tutti di seguire i lavori, è disponibile anche la diretta streaming sul canale YouTube della nostra Fondazione, qui.
Presentare e condividere le esperienze maturate nel corso del progetto Territori Generativi: è con questo obiettivo che IFEL organizza l’evento “I territori generativi. Esperienze di ricomposizione” previsto per il prossimo 3 aprile a Milano presso la sede di ANCI Lombardia.
Realizzato da IFEL con il supporto scientifico del Centro di Ricerca ARC dell’Università Cattolica, il supporto operativo di ON! e con il co-finanziamento della Fondazione Cariplo, il progetto Territori Generativi ha puntato a rafforzare gli attori coinvolti, nel loro ruolo di coordinamento per la definizione di una strategia di ‘area vasta’ attraverso i Piani di Zona; per la progettazione e la creazione di Case di Comunità e Punti Unici di Accesso; per la creazione del budget di salute; per dare concretezza ad azioni di amministrazione condivisa. Operativamente, si è sperimentato un metodo orientato a superare la frammentazione e la debolezza della capacità di coordinamento e integrazione tra gli attori ai quali è affidata l’efficacia del welfare locale, affrontando anche la questione della frammentazione delle risorse che arrivano sui territori.
Leggi il programma completo qui.
Il contesto
Secondo la visione che emerge dagli studi e dalle esperienze sul campo realizzate da IFEL, in collaborazione con il Centro di Ricerca dell’Università Cattolica ARC, per il benessere delle popolazioni e dei territori serve un nuovo welfare che sia generativo ovvero che:
- riesca a superare i vincoli dati dai silos organizzativi e da quelli prodotti dalla frammentazione e dalla verticalità delle risorse economiche trasferite ai territori;
- autorizzi ed abiliti gli attori del territorio (ETS, altre istituzioni, imprese, cittadini, sistemi della ricerca, ecc.) a pensare, progettare ed agire secondo logiche nuove di alleanze per il valore condiviso;
- si concretizzi grazie ad una regia pubblica forte, che traduca gli effetti di queste nuove alleanze in politiche pubbliche inclusive, capacitanti, orientate alla sostenibilità.
Per consentire al welfare di essere generativo servono due precondizioni rilevanti: creare, nei Comuni e nel loro ecosistema relazionale, alcune condizioni giuridiche, amministrative, organizzative e progettuali e abilitare le comunità ad agire le interazioni necessarie per il cambio di paradigma immaginato.
Il Progetto Territori Generativi
Il progetto negli anni ha lavorato proprio per realizzare nei Comuni coinvolti tali precondizioni. Operativamente, si è sperimentato un metodo orientato a superare la frammentazione e la debolezza della capacità di coordinamento e integrazione tra gli attori ai quali è affidata l’efficacia del welfare locale, affrontando anche la questione della frammentazione delle risorse che arrivano sui territori.
L’evento “I territori generativi. Esperienze di ricomposizione” si propone di presentare e condividere le esperienze realizzate sul campo: presentare il metodo di lavoro che ha reso possibile la ricomposizione, il coordinamento e l’integrazione dei diversi attori (con le loro responsabilità e i loro interessi), parte del welfare locale e riflettere, insieme, sulle modalità di ricomposizione della spesa (pubblica e privata) per un welfare locale più efficace.
Come partecipare
L’evento Territori Generativi si terrà il 3 aprile dalle ore 9:30 alle ore 13:00 presso la sede di ANCI Lombardia in Via Rovello 2 a Milano. Per partecipare in presenza è necessario iscriversi compilando questo form. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione.
GUARDA IL VIDEO
Di seguito riportiamo un estratto del Corriere della Sera di oggi con l’indagine condotta da Milena Gabanelli e Andrea Priante in Dataroom sulle imposte comunali e quanto incidono nelle spese delle famiglie. “Dataroom i conti li ha fatti con l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) che ha analizzato i dati 2015-2024 del 93% dei Comuni italiani: escluse solo le tre regioni autonome del Nord – Trentino Alto Adige, Friuli e Valle d’Aosta - perché hanno un sistema di finanziamento difficilmente paragonabile con il resto d’Italia. Salta fuori che tra imposte locali, tariffe e servizi comunali, rispetto a dieci anni fa le famiglie italiane pagano 4 miliardi di euro in più”…
…”Andrea Ferri, responsabile finanza locale dell’IFEL fa il punto: "Negli ultimi 15 anni i trasferimenti da parte dello Stato sono stati progressivamente trasformati in nuove imposte o in addizionali, e poi abbattuti con le manovre intervenute tra il 2010 e il 2015. Da allora in poi si tratta di trasferimenti quasi sempre vincolati a specifici servizi e voci di spesa, e quindi i sindaci non sono liberi di utilizzarli per fronteggiare l’aumento dei costi ordinari necessari a far funzionare le città. E questo costringe i Comuni a ulteriori aumenti di tasse e tariffe locali". È vero che ai Comuni sono arrivati sostegni importanti, come i 300 milioni destinati a finanziare l’affido (ai sindaci) dei minori da parte dei Tribunali (un dramma sociale peraltro sempre più in crescita), ma le ultime due manovre prevedono da qui al 2029 tagli per 740 milioni e accantonamenti per 1,3 miliardi. Alla fine dunque sono i sindaci a dover tappare i buchi. Le parole del presidente dell’Associazione dei Comuni Gaetano Manfredi sono molto chiare: "Non possiamo più intervenire sulle addizionali perché sono già spinte al massimo, pertanto il rischio è quello di peggiorare la qualità dei servizi, o di essere costretti a tagliarli”.
Guarda il video di Milena Gabanelli con il Dataroom qui.
Ascolta l’intervista di Radio Rai al Presidente di Alessandro Canelli.
Guarda il servizio del TGLa7 (minuto -8:40)
Leggi l’articolo del Corriere in allegato.